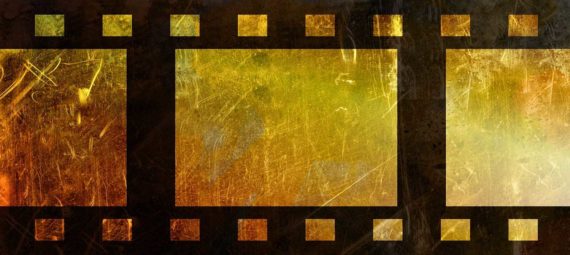Nell’ultimo decennio chissà in quante occasioni, mettendoci in coda davanti agli sportelli della stazione o sedendoci in attesa dell’inizio di una conferenza, ci sarà capitato di ascoltare borbottii come questi: «Ieri ho accompagnato mia nipote al cinema: sarà un fatto generazionale ma non riuscivo proprio a raccapezzarmi con la trama, tanto era concitata!», «Ricordi il kolossal della settimana scorsa? Trucchi superbi, certo, ma idee nuove neanche a pagarle a peso d’oro!», «Sarà possibile tornare al cinema di una volta, riflettendo ed emozionandoci al tempo stesso?» … Il tutto può forse essere ricondotto all’attuale crisi, influente sul piano intellettuale prima ancora che socio-economico, o forse le cause sono ben più profonde e riguardano il concetto stesso di Narrativa di cui il mezzo cinematografico è un’espressione: non è da escludersi che siamo agli sgoccioli di un lungo processo di “necrosi comunicativa” le cui avvisaglie siano da individuarsi in tempi più remoti. Guidato da alcune suggestioni fornite da Franz Altheim (1898-1976), filologo tedesco fra i maggiori del Novecento, l’articolo in oggetto propone un tentativo di lettura del processo summenzionato.
Approssimandosi la fine del primo ventennio del secolo (2000-2020), chissà in quante occasioni, mettendoci in coda davanti agli sportelli della stazione o sedendoci in attesa dell’inizio di una conferenza, avremo ascoltato discorsi del genere: «Ieri ho accompagnato mia nipote al cinema: sarà un fatto generazionale ma non riuscivo proprio a star dietro al ritmo della narrazione, tanto era concitato!», «Ricordi il kolossal della settimana scorsa? La trama, di per sé non nuova, mi sembrava poco più di un pretesto per esibire trucchi elaborati». Debolezza strutturale del racconto, idee riciclate, trionfo di effetti visivi, rimpianto verso un’epoca ‘indefinita’, passataci di sghembo con i suoi prodotti di cui si ha una cognizione altrettanto vaga: queste ed altre impressioni paiono agitarsi negli animi di coloro che tutt’ora si ostinano a preferire le sale di proiezione alle lusinghe del tubo catodico. In tempi di crisi, parafrasando il critico Maurizio Cabona, l’industria filmica “punta sull’usato garantito” il che è senz’altro vero: gli aspetti prima osservati si possono, infatti, ricondurre, sebbene solo in parte, all’attuale crisi, influente sulle forme di creatività prima ancora che sull’adesione a certi modelli economico-finanziari; già tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta del ‘900 diverse pellicole – da Splendor di Ettore Scola a Two bits di James Foley – annunciavano che la settima arte (in particolar modo, la sala come spazio-simbolo della sua fruizione) stava estinguendo i suoi ultimi fuochi per colpa di un uso quasi ‘bulimico’ di ritrovati tecnologici (vhs, canali televisivi e ora, con flessibilità anche maggiore, computer portatili e altri supporti di memoria) che hanno finito per liquefarla, rendendola ‘onnipresente’ (cfr. Hobsbawn E., Il secolo breve, XVII cap.); ciò veniva spesso argomentato con le lacrime agli occhi, sfogo che, col senno di poi, appare tanto contagioso quanto impreciso e prematuro. Oggi più che trent’anni fa risulta, dunque, necessario (anche se rischioso) riesaminare il mutamento della comunicazione audiovisiva, inquadrandolo nella totalità delle sue sfaccettature e tenendo conto dei nuovi bisogni del pubblico: l’articolo in oggetto non si arroga di assolvere tale compito (rinviato a ben altri studi), al limite vorrebbe invitare cinefili ed appassionati a ripensare il proprio armamentario teorico alla luce di alcune suggestioni, in primo luogo cominciando a rammentare che il secolare processo di trasformazione dell’organismo-cinema (ossia da semplice fenomeno di curiosità a vera e propria industria dello spettacolo) non è un fenomeno lineare e progressivo come sembrerebbe bensì un fenomeno ciclico (non lontano dal chiudersi, come espliciteremo alla fine), in secondo luogo riflettere su quale forma narrativa il cinematografo, fin dai suoi primi vagiti in Francia (si vedano i fortunati Lo scannatoio e I misteri di Parigi di Albert Cappellani) e negli USA (The Sealed Room di David W. Griffith), adottò per facilitare il cambiamento suddetto, consolidando perciò il dialogo con il pubblico: il romanzo.
Risulta difficile contraddire Ted Brautigan (Anthony Hopkins) in Cuori in Atlantide quando afferma trasognato “I grandi scrittori ci fanno passare delle belle serate da secoli” e altrettanto futile sarebbe disconoscere la facoltà di certe opere (comprese piccole pubblicazioni ancorate all’universo di provincia) di abituare il fruitore ad uno sguardo ‘intimo’, capace di penetrare il mero dato sensibile vincendo così, fosse anche per il tempo di una sola lettura, la superficialità imposta dal mondo esterno; tuttavia il fatto che a partire dalla fine del XIX secolo il romanzo abbia assunto una posizione di privilegio rispetto a generi tipici delle civiltà tradizionali quali l’epos, la lirica o la tragedia non è da prendere sottogamba. La montatura del romanzo, infatti, aveva già in sé il seme dell’intrattenimento odiernamente inteso ossia un sistema complesso che, grazie ad un oculato esercizio, suscita puntualmente (quando non meccanicamente) nel pubblico date emozioni. Nel suo saggio La forma cinematografica (1949) Sergej Ėjzenštejn scrisse poche ma memorabili pagine (cfr. cap. VII) in proposito, prendendo ad esempio Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas: chi non è stato affascinato – si interroga il cineasta russo – da Edmond Dantès, dalla “classica armonia della struttura labirintica” delle sue gesta? Chi non è stato colpito “dalla logica fatale che intreccia e intesse i personaggi e i fatti del romanzo, come se questi reciproci rapporti fossero esistiti sin dal momento in cui il romanzo fu concepito?” Ebbene, l’architettura del libro non è certo da attribuirsi ad una ‘visione divina’ che ha abbacinato l’Autore, piuttosto è il frutto di una ‘feroce diligenza’, l’opera di un ‘tecnico’ (o di un manipolo di tecnici) che cercò alacremente, sotto la minaccia di una scudisciata, di congelare in una forma quella caotica tempesta di sentimenti e azioni che è il consorzio umano (eventi storici, traversie private etc.). Fra i contemporanei di Dumas furono in molti ad accusarlo di aver dato avvio, con i suoi manoscritti, ad un processo di ‘industrializzazione’ della forma-romanzo, paradossalmente potremo persino affermare che quanto annotò Ėjzenštejn anticipi di più di vent’anni le riflessioni del filosofo Gilles Deleuze sull’inesorabilità della ‘Macchina’ alla quale, aggiungiamo noi, non si sottrarrebbe neppure l’arte dello scrivere. Ma andiamo con ordine.
Due anni dopo Ėjzenštejn, Franz Altheim (1898-1976), uno fra i maggiori filologi tedeschi, pubblicò un breve studio critico intitolato Romanzo e decadenza – probabile compendio di quanto trattò nei due tomi de Letteratura e società nella tarda antichità (1948-’50) – dal quale emerge una visione, se possibile, ancor più scomoda del genere letterario in esame. Ovunque si sia affermato, il romanzo – spiega Altheim – è stato percepito come espressione essenzialmente volgare: i Cinesi lo consideravano, in rapporto ai classici, soprattutto alla poesia, come espressione di decadenza spirituale; anche nel mondo islamico il romanzo viene tutt’ora rifiutato dalle classi elevate. Ad un’opera letteraria si richiede infatti che, per quel che concerne forma e contenuto, debba servire ad uno scopo specifico, e che non abbia la funzione di puro intrattenimento. Così i romanzi – prosegue il filologo – attecchiscono soltanto ai livelli inferiori della vita letteraria poiché essi, compresi i primi esemplari pervenutici dall’antichità (cfr. pseudo-Callistene e libri di gesta medio-persiane), non rendono testimonianza dell’estro di un popolo o dell’intelaiatura compatta dei suoi saperi bensì della nostalgia per essi tanto che l’amarezza per l’impossibilità di un loro pieno ritorno viene lenita, appunto, mediante la fuga verso un altro mondo, lontano, migliore, che purtroppo ha nella pagina di finzione il suo unico referente. Oltretutto, a differenza del linguaggio dell’epos o della tragedia, i quali sottostanno a norme comuni che li limitano rigidamente (espressioni fisse, ripetizioni di epiteti), il linguaggio del romanzo si apre ai più diversi influssi, abbracciando la totalità della vita. In Balzac, ad esempio, si ravvisa un ‘caos gigantesco’ dove una riflessione filosofica può di colpo cedere il posto ad un aneddoto sconcio, un accurato quadro sociale ad un patema d’amore e così via … Ciò non significa, beninteso, che il linguaggio del romanzo, sviluppatosi poi ad alti livelli, sia privo di forma. Anzi, vi furono scrittori che potevano addirittura sacrificare decenni in nome della perfezione stilistica e la fecondità del legame fra il romanzo e il linguaggio cinematografico sussistette fintanto che entrambi furono mossi dalla stessa, assidua ricerca della forma. Tra le prove pertinenti rientrano proprio le riduzioni filmiche, firmate da grandi maestri nell’arco dell’intero secolo, di alcuni fra gli scrittori ricordati: Ihara Saikaku (La vita di Oharu [1952] di Mizoguchi Kenji), J. W. Goethe (Le roman de Werther [1938] di Max Ophüls), Karel Hynek Mácha (Gli zingari [1922] di Karl Anton), Edgar Allan Poe (La caduta della casa Usher [1928] di Jean Epstein), Gustave Flaubert (La valle del peccato [1993] di Manoel de Oliveira), Ivan Turgenev (Nido di nobili [1969] di Andrej Končalovskij), Oscar Wilde (Il ritratto di Dorian Gray [1945] di Albert Lewin), Pierre Louÿs (Capriccio spagnolo [1935] di Josef von Sternberg), Thomas Mann (La morte a Venezia [1971] di Luchino Visconti), James Joyce (The Dead [1987] di John Huston), D. H. Lawrence (Donne in amore [1969] di Ken Russell), Marcel Proust (Il tempo ritrovato [1999] di Raúl Ruiz) … e ve ne sono certamente altri.
Una volta il mondo poetico – ribadisce Altheim – viveva assieme al Mito, portatore di valori. Questo aveva per lungo tempo accumulato in sé tutti i significati e i valori, tutti gli ideali della vita. Ma il Mito andò distrutto, non aveva più alcun valore; così l’espressione poetica della vita trovò forma soltanto attraverso i lati notturni ed oscuri dell’esistenza. Se, dunque, il cinema delle origini fosse stato in potenza ‘Mito Ritornante’, benché ‘vestito’ di tecnologia (il francesista Giuseppe Scaraffia lo definisce, infatti, ‘mito minore’), cosa avrebbe dovuto fare per costituirsi pienamente come tale? Di sicuro non provare a dar forma ai generi narrativi tradizionali più volte ricordati poiché nell’Europa moderna – come, in Arte, si poteva già intuire dagli svenevoli sentimentalismi degli imitatori di Jacques-Louis David – il richiamo all’Antico, in particolare al mondo ellenico, ‘finisce’ quasi automaticamente nell’arredo di scena del ‘vaudeville’, nella tappezzeria del bordello di lusso (ciò avvenne, ad esempio, nei corti osé Diana al bagno, Il ratto delle schiave, Svaghi della giovinezza, tutti girati dall’austriaco Johann Schwarzer tra il 1906 e il 1907) oppure, restando sul nostro oggetto di analisi, nel calderone falso-storico alla Bulwer-Lytton (come continua ad accadere oggigiorno e il tronfio Pompei di Paul W. S. Anderson è solo uno dei tanti titoli). No, la vera conquista sarebbe stata individuare il corrispettivo ‘in celluloide’ della forma chiusa caratteristica della narrazione arcaica e in questa sede suggeriamo (utopicamente e non senza un po’ di dubbio autocritico) che potesse essere l’assoluta e dominante ‘superficialità’ propria delle ‘vedute’ dei fratelli Lumière e coevi pionieri, in altre parole la pura e semplice ‘cattura’ di frammenti di realtà, di per sé casuali se non infimi ma che, nell’atto della proiezione, vengono come ‘depurati’ ed elevati ad immagini ‘assolute’: la giovane madre che allatta al seno, seduta su una panchina del Parc Monceau, una volta immortalata dalla cinepresa, già non è più una madre ma giunge agli occhi dello spettatore come l’idea della Maternità; i giovanotti di Lion-sur-Mer che si tuffano da un pontile cessano di essere comuni villeggianti in cerca di refrigerio, facendosi pura emanazione della Giovinezza (degna di alcune tele del danese Severin Krøyer); ciò vale per la cattura di fenomeni astronomici (L’Eclisse parziale di sole del 17 aprile 1912) o di un piovasco improvviso sulle strade di Amsterdam (Regen; 1929). La trasfigurazione avviene istantaneamente, senza appigli psicologici o simbolismi: il Simbolo – disse, infatti, il cineasta Andrej Tarkovskij – può essere interpretato, l’Immagine no. Scrisse, ironico, Enrico Ghezzi che si può mangiare dolciumi in pace guardando i trucchi di Georges Méliès (Filmcritica, 217, ’77) e ugualmente, aggiungiamo noi, si può fare con le ‘vedute’ del duo di Besançon: non perché gli attori recitino male o la narrazione non sia avvincente, piuttosto perché non ci sono attori e non vi è narrazione (se non ‘embrionale’ o involontaria). Soltanto l’Immagine nella sua pienezza. Rituale, ciclica nell’apparizione quanto il ricorso nel poema ad epiteti come ‘ῥοδοδάκτυλος Ἠώς’ (‘alba dalle rosee dita’): canonica, identica eppure ogni volta ‘nuova’ per l’emozione che suscita. È difficile pensare ad un cinema così fragile, così arretrato e così avanzato al tempo stesso, perciò prevedibilmente destinato (come fu) alla sconfitta. La vorace narrazione ‘romanzesca’, con tutti i pro e i contro, ha vinto e, affievolitasi attualmente la ricerca della forma tanto nei ‘vecchi’ maestri (si pensi alle ultime fatiche degli italiani Ermanno Olmi, Bernardo Bertolucci o del greco Theo Angelopoulos) quanto nelle non più giovani promesse (es. il danese Lars von Trier, l’armeno Atom Egoyan o il sudcoreano Kim Ki-duk), rimangono solo i tratti che le furono propri fin dal principio cioè il basso (es. commedie bonarie o prodotti che includono velata propaganda, di ogni tipo), il mistico-superstizioso (es. Legion, Left Behind, 2.22: Il destino è già scritto), e l’osceno nelle sue molteplici accezioni (es. Thanatomorphose, 50 sfumature di grigio, Sausage Party). Ciò nonostante intravediamo una via d’uscita: la settima arte, come ipotizzato all’inizio dell’articolo, ha già compiuto il suo secolare ‘giro di valzer’. Il cerchio sta per chiudersi. Sebbene non ancora espressa si sta facendo strada – sia nel pubblico sia nei cineasti di generazioni diverse – la volontà di ricongiungersi alle origini, allo stupore scaturente dalle pure immagini. Non sarà facile rinnovare una simile ‘innocenza’ di sguardo. Il ‘palombaro’ del cinema riemerge lentamente dagli abissi, sfiancato dal peso dello scafandro (il caos della forma-romanzo) e dalle lunghe soste di decompressione (mode, effimere sperimentazioni, interventi del Potere o, comunque, di mani estranee alla creatività) eppure, accostando l’orecchio al suo elmo, sarà possibile intendere questi quattro ‘segnali’:
- Saturazione dell’immagine ‘convulsa’: Spy Kids 2 (2002) di Robert Rodríguez e il recente Transformers 5 – L’ultimo cavaliere (2017) di Michael Bay sono accomunati da quello che il politologo Aleksandr Dugin, rifacendosi ad un’invenzione del primo film, ha definito ‘il rimedio del maiale volante’. Il pubblico per cui sono stati concepiti, perlopiù ‘televisivo’, è già partecipe di microprocessi emotivi a motivo dei quali, se non riceve la sua ‘dose’ di spettacolo, entra subito in crisi di astinenza. Non si tratta però di uno spettacolo coeso bensì un convulso mosaico di materiali eterogenei. Perciò sia Bay che Rodríguez si vedono più o meno costretti ad allestire un lauto banchetto di modo che sarà impossibile per gli spettatori distrarsi. Palpebre calanti? Niente paura, un ‘maiale volante’ solcherà il cielo e tale sarà la repentinità della trovata da rinnovare subito l’attenzione, a prescindere dal fatto che con la ragione se ne veda poi l’assurdità intrinseca. Spenta la curiosità per il maiale, seguirà un robot che si tramuta in un’utilitaria etc … con Enter the Void (2009) l’argentino Gaspar Noé compone un’involontaria satira (il titolo è eloquente: ‘Entra nel vuoto’) di questa moderna dipendenza dall’immagine ipertrofica, distruggendo l’ultimo elemento non irrisorio, irrilevante o minimo della realtà, cioè l’essere umano, reso irriconoscibile per mezzo di gelatine colorate, distorsioni ottiche e fosforescenti forme urbane che lo assorbono.
- Nostalgia delle origini: pellicole come Parla con lei (2002) di Pedro Almodóvar, Hugo Cabret (2011) di Martin Scorsese, Cirque du Soleil: Le voyage imaginaire (2012) di Andrew Adamson, Il grande e potente Oz (2013) di Sam Raimi, Mister Babadook (2014) di Jennifer Kent, Planetarium (2016) di Rebecca Zlotowski rievocano, ciascuna in modo completamente diverso, quel misto di paura e meraviglia che ispiravano le ‘burle’ circensi di Méliès o di Segundo de Chomón. I corti del canadese Guy Maddin, The Artist (2011) di Michel Hazanavicius e Blancanieves (2012) di Pablo Berger sono addirittura girati e recitati alla maniera dell’era del muto.
- Rinuncia al linguaggio: nel delicato Words & Pictures (2013) di Fred Schepisi due docenti, aiutati dalle rispettive classi, si interrogano se sarà mai possibile trovare un ‘pianeta’ dove gli uomini comunicheranno aldilà delle immagini e delle parole. Innocue fantasie delle fiabe moderne. La questione è ben più ispida. All’interno di una società industriale sempre più meccanizzata, il primo a risentirne è proprio il linguaggio – incrinato da neologismi e semplificazioni varie – come denuncia l’avveniristico Il cerchio (2017) di James Ponsoldt i cui dialoghi sono, infatti, provocatoriamente ai limiti dell’inintelligibile, per non dire di The Square (2017) di Ruben Östlund che presenta la sindrome di Tourette e l’incapacità di pensare in maniera astratta come effetti estremi del problema. The tribe (2014) di Myroslav Slaboshpyts’ky ‘diserta’ perfino la parola, preferendole la lingua dei segni; priva lo spettatore udente di rassicuranti sottotitoli e lo getta in pasto ad una ‘Nuova Preistoria’ dove regnano silenzio e movenze ferine che paiono affiorare dalla notte dei tempi. Addio al linguaggio, recita il titolo dell’ultimo film (2014) di Jean-Luc Godard che potrebbe benissimo assurgere a motto silenzioso di un nuovo manifesto di stile espressivo.
- Risveglio dell’immagine ‘assoluta’: l’immagine ‘assoluta’ accompagnò, come sopra menzionato, i primi passi del cinematografo. Alla fine degli anni Ottanta del ‘900, timorosi che l’occhio ormai saturo dello spettatore non possedesse più quell’originaria facoltà ‘sublimante’, cineasti come Godfrey Reggio e Ron Fricke cercarono di risvegliare tale facoltà potenziando le immagini dei loro ‘cine-diari’ di viaggio – cfr. Koyaanisqatsi (1983) o Chronos (1985) – mediante il continuo ricorso al rallentatore, al teleobiettivo, all’accelerazione, più specificamente perfezionando una tecnica denominata time-lapse (fotogrammi a intervalli di tempo superiori rispetto alla norma). Astuzie tutte carpite e presto volgarizzate dai creativi pubblicitari, al punto che ci domandiamo tutt’ora se valga la pena immortalare con mezzi all’avanguardia l’Árbol de Piedra boliviano o le spettacolari mareggiate del Nord dell’Inghilterra per reclamizzare liquori e profumi. Le maglie dell’estetica mercantile-pubblicitaria sembrano, però, allentarsi gradualmente. La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino ha avuto il merito di riutilizzare tale estetica in funzione critica, esacerbandola, per svelare la fatuità del pensiero su cui essa poggia. Contemporaneamente, pur peccando ancora di estetismo, ambiziosi poemi visivi quali ¡Vivan las antípodas! (2011) di Victor Kossakovsky, Il était une forêt (2013) di Luc Jacquet, Do que vem antes (2014) di Lavrente Diaz, Still the Water (2014) di Kawase Naomi, El abrazo de la serpiente (2015) di Ciro Guerra, Pace nei nostri sogni (2015) di Sharunas Bartas, Voyage of Time (2016) di Terrence Malick hanno cercato comunque a trasmutare il Paesaggio – sia esso occitano, andino, tropicale, nipponico o lituano – in pura Idea, pura Immagine del Giardino Primigenio dove la Civiltà e i suoi ‘oggetti’ non hanno fatto ancora la loro comparsa.
Siamo consapevoli che le conclusioni siano state formulate in modo schematico ma se ciò indispettirà più di un lettore allora avremo raggiunto l’obiettivo: far sì che tale proposta interpretativa sul futuro della comunicazione filmica assomigliasse ad un laboratorio d’indagine, aperto al confronto e ad ogni sorta di contributo. Che aspettiamo.